MARC CHAGALL
"E’ buio. All’improvviso si spalanca il soffitto; un tuono, un lampo di luce ed ecco irrompere nella stanza un’impetuosa creatura alata, avvolta in volute di nuvole, un forte fremito di ali. Un angelo! Penso io. Ma non riesco ad aprire gli occhi: dall’alto sgorga una luce troppo forte. L’ospite alato vola per tutti gli angoli della stanza, si solleva nuovamente e vola via attraverso la fenditura del soffitto, portando con sé il fulmine e l’azzurro. E di nuovo torna il buio. Mi sveglio”.
Così scrive Marc Chagall nelle sue memorie per sottolineare l'attenzione verso l'aspetto visionario e surreale della realtà, verso il sogno che irrompe nell’esperienza notturna, che si irradia nella mente e nel ricordo e da questo nel “fare” artistico.
Marc Chagall nacque in una famiglia ebraica a Lëzna, presso Vitebsk, una città di lingua yiddish oggi in Bielorussia. Il giorno stesso della sua nascita, il villaggio venne attaccato dai cosacchi durante un pogrom e la sinagoga fu data alle fiamme; da allora, l'artista - rievocando le proprie origini - userà dire: "Io sono nato morto". Chagall era il maggiore di nove fratelli; il padre, Khatskl (Zakhar) Chagall, era un mercante di aringhe.
Nelle opere dell'artista ritorna spesso il periodo dell'infanzia, felice nonostante le tristi condizioni degli ebrei russi sotto il dominio degli zar e il cui onnipresente ricordo condizionerà tutta l'opera futura.
Dopo aver convinto la sua famiglia, riluttante a fargli intraprendere la carriera artistica in quanto cosa espressamente vietata dalla Torah, Chagall dapprima lavorò assai di malavoglia come ritoccatore nella bottega di due fotografi, ma nel 1906 iniziò a studiare pittura con il maestro Yehuda (Yudl) Pen, il solo pittore di Vitebsk: rimarrà nel suo studio pochi mesi, non ritrovandosi nell'insegnamento accademico del maestro, e l'anno successivo si trasferì a San Pietroburgo. Qui frequentò l'Accademia Russa di Belle Arti con una borsa di studio, e conobbe artisti di ogni scuola e stile. Tra il 1908 e il 1910 studiò prima in una scuola privata, poi alla scuola Zvantseva.
Per mantenersi agli studi a San Pietroburgo, Chagall diventò artigiano e dipinse insegne di negozi, oltre alle prime opere originali. Questo fu un periodo difficile per lui: gli ebrei potevano infatti vivere a San Pietroburgo solo con un permesso apposito e venne persino imprigionato per breve tempo per essere rimasto fuori dal ghetto oltre l'orario consentito. Rimase nella città fino al 1910, anche se di tanto in tanto tornava nel paese natale, dove nel 1909 incontrò, grazie alla modella e amica Thea Brachman, Bella Rosenfeld, figlia di ricchi orefici e sua futura moglie. Nel 1912 aderì alla Massoneria.
Una volta divenuto noto come artista, nel 1910 Chagall lasciò San Pietroburgo per Parigi per avvicinarsi alla comunità artistica di Montparnasse: «Nessuna Accademia avrebbe potuto darmi tutto quello che ho scoperto divorando le esposizioni di Parigi, le sue vetrine, i suoi musei [...] Come una pianta ha bisogno di acqua, così la mia arte aveva bisogno di Parigi», dirà poi. Qui si stabilì presto alla Ruche e strinse amicizia con Guillaume Apollinaire, Robert Delaunay, Fernand Léger e Eugeniusz Zak; manterrà però un certo scetticismo nei confronti del cubismo, considerandolo troppo "realista" e attaccato al lato fisico delle cose, mentre lui si sentiva più attratto «dal lato invisibile, quello della forma e dello spirito, senza il quale la verità esterna non è completa».
In questo periodo dipinse i suoi primi capolavori, nei quali il ricordo di casa e dello Shtetl è predominante: alla Russia, agli asini e agli altri, Il Santo vetturino, Io e il villaggio.
Il poeta Cendrars gli dedicò quattro dei suoi Poemes élastiques e Apollinaire, riferendosi alla sua pittura, la definì "soprannaturale".
Chagall potrà affermare con soddisfazione: «Ho portato dalla Russia i miei oggetti, Parigi vi ha versato sopra la sua luce».
Nel 1914 l'artista ritornò a Vitebsk fermandosi a Berlino, dove il mercante d'arte Herwarth Walden organizzò nella propria galleria la prima personale che ebbe un ottimo successo di pubblico e critica. Poco dopo il ritorno in Russia, scoppiò la Prima guerra mondiale che, insieme alla successiva rivoluzione, lo terrà di fatto bloccato in patria fino al 1923. Intanto, nel 1915 si era unito in matrimonio con Bella Rosenfeld; nel 1916 nacque la loro prima figlia, Ida.
A Vitebsk, dove ritrovò la famiglia, Chagall dipinse opere come L'Ebreo in rosa, L'ebreo in preghiera, La passeggiata e Compleanno. Nel 1917 prese parte attiva alla rivoluzione russa: in sostituzione del servizio militare, lavorò a Pietroburgo al Ministero della Guerra, dove conobbe i grandi poeti russi del periodo (Pasternak, Esenin, Majakovskij), realizzò le prime illustrazioni per libri e giornali ed espose in alcune importanti collettive. Il Ministro sovietico della cultura Lunačarskij lo nominò Commissario dell'arte per la regione di Vitebsk, dove fondò una "Libera Accademia d'Arte" e il Museo di arte moderna; non ebbe tuttavia successo nella politica del governo dei soviet. Chagall incitò gli artisti di ogni età ad abbandonare gli atelier e portare il loro contributo alla preparazione della festa, oltre che a seguire il proprio estro creativo: così, le opere decorative per il primo anniversario della Rivoluzione scontentarono i funzionari del governo che, in luogo dei ritratti trionfali di Marx, Engels e Lenin, si ritrovarono effigi di mucche e cavalli volanti ed umanizzati. Per questo, Chagall entrò in contrasto con la sua stessa scuola, conforme per motivi politici al suprematismo, assolutamente agli antipodi rispetto al suo stile fresco ed "infantile". Dopo un breve viaggio a San Pietroburgo il pittore trovò al ritorno la sua stessa scuola trasformata in una "accademia suprematista". Di conseguenza, nel 1920 Chagall fu costretto a dimettersi e si trasferì con la moglie e la figlioletta a Mosca, dove il governo gli affidò l'insegnamento dell'arte agli orfani di guerra, mestiere di certo più limitante del precedente. Nello stesso periodo accettò la commissione per la decorazione di nove pannelli (oggi ne rimangono 7) per il Teatro Ebraico di Stato "Granovskij" e disegnò una serie di illustrazioni per il ciclo di poesie in yiddish Grief del poeta David Hofstein, anch'egli insegnante presso il rifugio Malakhovka.
Amareggiato, nel 1923 Chagall riuscì finalmente a lasciare la Russia rivoluzionaria grazie all'ambasciatore lituano e, dopo un breve e sofferto soggiorno a Berlino (i quadri che vi aveva lasciato erano andati distrutti o dispersi a causa della guerra) e una commissione del gallerista Cassirer, si trasferì a Parigi, dove ritrovò alcuni dei vecchi contatti. In questo periodo pubblicò le sue memorie in yiddish, trascritte inizialmente in russo e poi tradotte in francese dalla moglie Bella; scrisse anche articoli e poesie pubblicati in diverse riviste e alcuni scritti raccolti in forma di libro e pubblicati postumi. Il mercante Ambroise Vollard gli commissionò varie illustrazioni (principalmente acqueforti), tra cui quelle per le Anime morte di Gogol', per le Favole di La Fontaine (queste ultime, iniziate negli anni '30 ed interrotte a causa della morte di Vollard e dello scoppio della guerra, verranno concluse e pubblicate solo negli anni'50), e soprattutto per la Bibbia, che sin dall'infanzia considerava il suo racconto preferito; per poterne assimilare l'anima il più possibile, all'inizio degli anni'30 Chagall e la famiglia compirono un viaggio in Palestina .
Nel 1937 acquisì la cittadinanza francese; durante l'occupazione nazista in Francia nella Seconda guerra mondiale e a seguito della deportazione degli Ebrei e dell'Olocausto, gli Chagall fuggirono da Parigi e si nascosero presso Villa Air-Bel a Marsiglia; il giornalista americano Varian Fry li aiutò poi nella fuga verso la Spagna e il Portogallo.
Nel 1941 la famiglia Chagall si stabilì negli Stati Uniti dove sbarcò il 22 giugno, giorno dell'invasione nazista della Russia.
Negli Usa, Chagall frequentò la numerosa comunità artistica fuggita dall'Europa e grazie all'aiuto del gallerista Pierre Matisse (figlio del celebre Henri) espose in numerose mostre collettive e non; nonostante l'intensa attività e i numerosissimi contatti con la cultura americana, però, si rifiuterà sempre di prendere la cittadinanza statunitense e di imparare l'inglese, continuando ad esprimersi in francese e in yiddish. Il 2 settembre 1944 l'amatissima Bella, soggetto frequente nei suoi dipinti e compagna di vita, morì per un'infezione virale mal curata. La sua morte fu un durissimo colpo per l'artista, che per quasi un anno non riuscì più a dipingere; uscirà dalla depressione solo grazie alla figlia Ida che, oltre a spronarlo a lavorare e fargli tornare l'amore per la vita, nel 1945 gli presentò la trentenne canadese Virginia Haggard McNeil, già separata da un pittore da cui aveva avuto una figlia e con la quale Chagall cominciò una relazione che durerà sette anni e che porterà alla nascita del figlio David il 22 giugno 1946. Durante questi duri anni di esilio negli USA, Chagall lavorò a numerose opere, ottenendo commissioni per lavori teatrali che si concretizzarono in imponenti e vivaci scenografie, come quelle per Aleko (settembre 1942, ispirato ad un poema di Puškin) o per L'uccello di fuoco del 1945 alla Metropolitan Opera House (delle cui scenografie e costumi ideati da Chagall e dalla figlia Ida, però, il compositore Stravinskij, grande ammiratore di Picasso, rimarrà insoddisfatto). Oltre a questi grandi lavori, l'artista realizzò anche le illustrazioni per le Notti arabe (ispirate alle Mille e una notte), riprendendo per l'editore newyorkese Wolff un'opera già richiestagli anni prima da Vollard; inoltre, collaborò con la rivista "Derriere le miroir", edita da Aimé Maeght, che diverrà, da quel momento, il suo principale mercante per l'Europa. Finita la guerra e passata la tempesta dell'Olocausto (che la sua anima sensibile non gli aveva permesso di dipingere direttamente, ma di evocare attraverso opere allegoriche), nel 1948 Chagall fa ritorno in Europa e, dopo un breve soggiorno a Parigi, nel 1949 si stabilisce ad Orgeval. Nel 1947 la Francia gli aveva reso omaggio con un'importante personale al Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris e l'anno successivo la Biennale di Venezia gli conferirà il Gran Premio per l'incisione. Un'altra importante antologica si tiene nel 1954 alla Galleria Maeght. In questi anni intensi, dopo l'austerità della guerra, riscopre colori liberi e brillanti: le sue opere sono ora dedicate all'amore e alla gioia di vivere, con figure morbide e sinuose. Agli inizi degli anni'50 l'editore Teriade gli pubblica tutte le opere commissionate da Vollard e rimaste fino ad allora inedite. Su consiglio dello stesso editore, Chagall acquista la tenuta Les Collines alle porte di Vence, in Provenza, dove si stabilisce definitivamente. Nello stesso periodo, la figlia Ida sposa il museologo svizzero Franz Meyer, mentre va rapidamente affievolendosi la relazione dell'artista con Virginia Haggard.
Stabilitosi nel sud, Chagall comincia a cimentarsi anche con la scultura, la ceramica e il vetro: prima ad Antibes, infine a Vallauris presso l'atelier Madoura gestito dai coniugi Ramié (dove incontra più volte Picasso, che vi lavora alacremente, e qualche volta anche Matisse), Chagall lavorerà a più riprese producendo vasi, sculture e bassorilievi con le forme dei temi a lui più cari: figure sacre e bibliche, immagini femminili, strani animali... Nel 1951, inoltre, Chagall conosce Valentina (detta "Vavà") Brodsky con cui, dopo un breve e travolgente idillio, si risposa nel 1952 a Clairefontaine, presso Rambouillet: anch'ella di origine russa ed ebrea, sarà la sua nuova musa ispiratrice, affiancando il ricordo di Bella nelle tele dell'artista che, con lei, scopre ben presto la Grecia e l'Arte Classica. Intorno alla fine degli anni '50 Chagall comincia a produrre arazzi e soprattutto vetrate: le prime sono quelle del battistero per la chiesa di Notre-Dame-de-Toute-Grace ad Assy, poi quelle per la cattedrale di Metz. Nel 1957 si reca nuovamente in Israele, dove nel 1960 crea una vetrata per la sinagoga dell'ospedale Hadassah Ein Kerem. Altre stupende vetrate sono realizzate, tra il 1958 e il 1968, per la cattedrale di Reims, e nel 1964 l'artista ne dona una all'ONU con tema pacifista, in memoria di Dag Hammarskjöld. Nuove opere su vetro vedono la luce per la Cappella dei Cordiglieri a Sarrebourg (1975), per la chiesa di S. Stefano a Magonza (1978) ed infine per la Chapelle du Saillant a Voutezac, nel Corrèze, nel 1982. Nel 1963 aveva ottenuto dal ministro Malraux la commissione per decorare il soffitto dell'Opéra di Parigi, che ornò con figure allegoriche di opere celebri; ritornerà poi ad allestimenti teatrali, con la messa in scena del Flauto magico nel 1965; poi nel 1966 progetta un affresco per il nuovo parlamento israeliano, mentre per l'università Knesseth realizza una serie di arazzi, tutti a sfondo biblico, con l'aiuto della celebre Manifattura dei Gobelins. Nello stesso anno per l'editore Amiel pubblica L'Esodo, una serie di 24 litografie a colori, ed intensifica l'attività grafica.
Durante la guerra dei sei giorni l'ospedale Hadassah Ein Kerem viene bombardato e le vetrate di Chagall rischiano di essere distrutte: solo una viene danneggiata, mentre le altre vengono messe in salvo. In seguito a questo episodio, Chagall scrive una lettera in cui afferma di essere preoccupato non per i suoi lavori, bensì per la salvezza di Israele, vista la sua origine ebraica. Nel 1972 esegue, per il comune di Chicago, un mosaico dedicato alle Quattro stagioni. Dopo tanti anni, invitato dal governo sovietico, nel 1973 torna anche in Russia, dove sarà accolto trionfalmente a Mosca e a Leningrado: qui ritrova, dopo cinquant'anni, una delle sorelle, ma si rifiuta di tornare nella nativa Vitebsk. Nello stesso anno -e nel giorno del suo compleanno- s'inaugura, a Cimiez vicino Nizza, il Museo nazionale messaggio biblico di Marc Chagall che riunisce le sue opere sulla Bibbia: si tratta di diciassette dipinti dedicati alla Genesi, all'Esodo e al Cantico dei Cantici e degli schizzi relativi agli stessi dipinti, donati allo Stato francese da Chagall e Vavà tra il 1966 e il 1972. Viaggia poi in Italia: nel 1976 un suo Autoritratto entra nella collezione degli Uffizi, e due anni dopo Palazzo Pitti gli dedica una mostra. Nel 1977 il Presidente Valéry Giscard d'Estaing lo nomina Cavaliere di Gran Croce della Legion d'onore, e una nuova imponente mostra personale s'inaugura al Louvre nell'ottobre del 1977.
Nello stesso anno, l'editore Maeght pubblica Et sur la Terre... di Malraux con le illustrazioni dell'artista. Le ultime esposizioni sono nel 1984 al Pompidou, al Museo di Nizza, ed infine l'imponente retrospettiva alla Fondazione Maeght tra luglio ed ottobre del 1984. Dopo una vita lunga e ricca di soddisfazioni artistiche e personali, Chagall muore a 97 anni a Saint-Paul-de-Vence, dove risiedeva, il 28 marzo 1985. Viene sepolto nel piccolo cimitero locale, dove nel 1993 lo raggiungerà Vavà.
Chagall nei suoi lavori si ispirava alla vita popolare della Russia europea e ritrasse numerosi episodi biblici che rispecchiano la sua cultura ebraica. Negli anni sessanta e settanta, si occupò di progetti su larga scala che coinvolgevano aree pubbliche e importanti edifici religiosi e civili. Le opere di Chagall si inseriscono in diverse categorie dell'arte contemporanea: prese parte ai movimenti parigini che precedettero la prima guerra mondiale e venne coinvolto nelle avanguardie. Tuttavia, rimase sempre ai margini di questi movimenti, compresi il cubismo e il fauvismo. Fu molto vicino alla Scuola di Parigi e ai suoi esponenti, come Amedeo Modigliani. I Iuoi dipinti sono ricchi di riferimenti alla sua infanzia, anche se spesso preferì tralasciare i periodi più difficili. Riuscì a comunicare felicità e ottimismo tramite la scelta di colori vivaci e brillanti. Il mondo di Chagall era colorato, come se fosse visto attraverso la vetrata di una chiesa.
Durante il suo primo soggiorno a Parigi rimane colpito dalle ricerche sul colore dei Fauves. Il suo mondo poetico si nutre di una fantasia che richiama all'ingenuità infantile e alla fiaba, sempre profondamente radicata nella tradizione russa. La semplicità delle forme di Marc lo collega al primitivismo della pittura russa del primo Novecento. Con il tempo il colore di Chagall supera i contorni dei corpi espandendosi sulla tela. In tal modo i dipinti si compongono di macchie o fasce di colore, sul genere di altri artisti degli anni Cinquanta appartenenti alla corrente del Tachisme (da tache, macchia). Il colore diventa così elemento libero e indipendente dalla forma.
LA BIBBIA
Chagall fu affascinato sin dagli anni giovanili dalla Bibbia, da lui considerata come la più importante fonte di poesia e di arte, ma è solo a partire dagli anni '30 che se ne interessò profondamente e iniziò a studiarla con dedizione. L'occasione per farne un lavoro giunse nel 1930, quando l'editore e mercante d'arte francese Ambroise Vollard, per il quale aveva già illustrato Le anime morte di Gogol' e Le Favole di La Fontaine, gli commissionò una serie di tavole dedicate al tema biblico. Chagall vi si dedicò con entusiasmo per tutto il decennio, tanto da intraprendere appositamente un viaggio sui luoghi delle vicende narrate dai Testi Sacri, tra Egitto, Siria e Palestina: da questo momento in poi, la Bibbia occuperà l'intera produzione artistica dell'autore, che ne fornirà un'interpretazione pur mediata dall'influenza delle avanguardie francesi.
I FIORI E LA NATURA
L’importanza dei fiori, quale espressione di vita pura, viene così espressa da Chagall: “Potresti chiederti per ore quale sia il significato dei fiori, ma per me sono la vita stessa, in tutto il suo felice splendore, non potremmo fare a meno dei fiori. I fiori ti aiutano a dimenticare le tragedie della vita.” Ancora sui fiori: “L’arte è lo sforzo incessante di competere con la bellezza dei fiori … senza mai riuscire a vincere.”
L'AMORE
Esiste un sogno in cui un uomo passeggia libero, tenendo per mano una donna che vola. Con lei, pian piano, anche lui si solleva da terra.
È la storia di Moishe Segal e Bella Rosenfeld, un amore invisibile ed eterno che si tinge di mercurio scintillante, di un anima blu.
L’incontro tra la giovanissima Bella e il pittore è al contrario il segreto più intimo della loro arte. Esso diviene così il fulcro di tutta la loro arte, motore di una ricerca continua in cui i materiali, i colori e le parole stesse altro non furono che strumenti e fraseggi di un unico dialogo. Marc parla a Bella e la sospende nel cielo, la rende elemento centrale dei suoi paesaggi. Lei, nello splendore della sua tradizione ebraica, è presente tra le righe dei suoi scritti e parla di lui. Lei è la sposa, è il blu, perché «Tutti i colori, salvo il blu oltremare, si bruciano e si ribruciano». (M. Chagall, La mia vita p.154)
La loro storia è vera, terrena, nonostante ciò che li legherà sembrerà trascendere il tempo. Si incontrano nel 1909 nella loro città natale di Vitebsk. Marc è un giovane di umilissime origini che non vuole accettare ciò che il destino sembra aver scritto per lui, quello di commerciare aringhe come il padre. Lui vuole altro, vuole dipingere e prova a farlo con la sua vena artistica, la sua inesperienza e un notevole talento naturale. Bella è ancora più giovane, proviene da una famiglia benestante ed è una brillante studentessa. Non sarebbero dovuti stare insieme, eppure da subito una forza magnetica e luminosa li unisce, abbattendo pregiudizi, divieti e ostracismi da parte soprattutto della famiglia di lei.
Quel primo incontro fu così determinante per le loro vite da rimanere impresso nelle memorie di entrambi.
A farli conoscere è Thea, un’amica comune, compagna di giochi per Bella e modella per Marc. Lui è a casa di Thea e sta riposando su un divano, quando suonano alla porta è infastidito, non vorrebbe essere disturbato. Ma all’improvviso arriva lei.
"La visita di quella fanciulla sconosciuta e la sua voce musicale, si direbbero dell’altro mondo, mi sconvolgono. Chi è, ho paura. Non voglio conoscerla, avvicinarmi a lei[…] mi guarda appena e se ne va. Usciamo, Thea e io, a passeggio. Sul ponte la incontriamo di nuovo. È sola, completamente sola. Bruscamente sento che non è con Thea che dovrei essere, ma con lei!
Il suo silenzio è il mio. I suoi occhi, i miei. È come se mi conoscesse da sempre, come se sapesse tutto della mia infanzia, del mio presente, del mio avvenire; come se vegliasse su di me, mi capisse perfettamente, sebbene la veda per la prima volta. Sentii che era lei la mia donna. Il suo colorito pallido, i suoi occhi. Come sono grandi, tondi e neri! Sono i miei occhi, la mia anima. Thea mi parve indifferente, straniera. Sono entrato in una casa nuova e non ne sono più uscito".
Da quel primo incontro passano quasi quattro anni prima che i due giovani possano rivedersi. Lui si trasferisce a Parigi e nonostante le difficoltà, e lo stato di povertà assoluta in cui vive, in quel periodo si forma come artista.
Nonostante la guerra imminente, lui vuole tornare in Russia, «Volevo rivedere lei. ..alla fine del mio soggiorno a Parigi non restava che un fascio di lettere. Ancora un anno e tutto, forse, sarebbe finito tra noi due». Ma lei è lì ad aspettarlo. La magia non è affatto sparita e così vogliono sposarsi nonostante la famiglia di Bella non approvi tale unione: lei benestante, lui figlio di un commesso, e per di più pittore. Marc fa spesso riferimento alle meravigliose tavole imbandite che trovava a casa della sua amata. Lì si preparavano torte enormi alle mele, al formaggio, al papavero alla cui sola vista Marc si sentiva svenire. «A casa nostra, invece, una semplice natura morta alla maniera di Chardin. Il loro padre si abbuffava di uva, il mio di cipolla;».(M.C.)
Fino all’ultimo la madre di Bella cerca di dissuaderla «Senti, mi sembra che si metta anche del rosso sulle guance. Che marito potrà mai essere questo ragazzo rosa come una fanciulla? non saprà mai guadagnarsi il pane, perirai per nulla figlia mia, per di più è un artista. Che cos’è?»
Ma che farci se lei vuole così. Che farci se entrambi si erano scelti, se Marc per lei ha parole bellissime, se lei è capace di illuminare la vita di entrambi.
Io aprivo soltanto la finestra della stanza e l’aria azzurra, l’amore e i fiori entravano con lei. Tutta vestita in bianco o in nero lei vola da molto tempo attraverso le mie tele, guidando la mia arte.(M.C. p. 125)
Così la loro unione a poco a poco, dall’essere motivo di ispirazione artistica, diviene essa stessa arte. Ricerca inquieta di un equilibrio ostacolato principalmente dal difficile momento storico che entrambi si trovano a vivere. Lui, ebreo russo, fin dalla giovinezza subisce le discriminazioni razziali degli zar, presagio di una più violenta persecuzione operata dal nazismo, che lo renderanno inquieto, «sento che tutto in me si torce, che io cammino in maniera strana sulla terra», «sono sempre inquieto e turbato da un nonnulla», «ne’ la Russia imperiale, ne’ la Russia dei soviet hanno bisogno di me. Io sono incomprensibile per loro». (M.C.) L’unico suo punto fermo è la sua anima, lì dove risiede Bella pronta a vegliare lui e le sue opere.
Il segreto che si nasconde dietro la loro chimica relazionale è proprio questo, un connubio di amore, tradizione, cultura ebraica e ferrea volontà. Loro non solo si stimolano e si aiutano nei rispettivi lavori, ma trovano nel senso del loro amore la chiave per la propria direzione artistica.
Fin da giovane subì e comprese il peso dell’antisemitismo, costretto a scappare da un paese all’altro, senza sentirsi mai a casa, se non vicino a Bella. Vietbesk, la città natale di entrambi fu a lungo scossa da rastrellamenti e incendi. Bruciarono le case dei loro vicini e perfino la sinagoga. La famiglia di lei subì furti e i cekisti, armati di fucili, continuarono a bucare pareti per cercare tesori. Ma anche fuori da Mosca la situazione non migliorò, i due dal giorno del loro matrimonio cambiarono infinite case. Vivevano in ripari umidi, con la neve che cadendo arrivava anche sul letto. E Bella, sempre abituata al benessere, non si lamentava. Per acquistare il latte per la sua piccola, la loro unica figlia, un giorno decise di portare i suoi gioielli al mercato e lì la milizia arrivò ad arrestarla. Anche Marc non si lamenta. Sapeva di stare bene e il resto a lui non interessava. Sapeva di poter ancora sollevarsi da tutto quel dolore, di poter uscire dalla finestra mano per la mano con Bella.
Chagall infatti si discosta dal cubismo, dal fauvismo, e, pur ispirandosene, non appartiene a nessun movimento artistico. Perché lui reagisce in modo differente, scompone e ricompone ogni accaduto secondo i propri sentimenti e ricordi. A quella dura realtà fatta di guerre, di persecuzioni e continue perquisizioni, all’affronto di vedersi bruciare le sue opere per mano dei nazisti, all’angoscia di non poter mai trovar rifugio, lui risponde con un nuovo linguaggio, si solleva da terra. A tanto dolore Chagall contrappone il sogno, l’amore, la spiritualità.
In altre parole rifiuta la distanza tra l’amore e il presente, tra la trascendenza e la carne e affida il suo animo a un volo. «Ho voluto collocare lassù in alto, come in un mazzo, i sogni e le creazioni degli interpreti e dei musicisti. Ho voluto cantare senza teoria, senza metodo, come un uccello». (M.C.).
Chagall teme, in qualche modo, di aver oscurato il talento della sua amata, costretta ad abbandonare il suo lavoro per il teatro e a seguirlo prima in Francia e poi in America. Lei, che era stata musa, protagonista di molte delle sue tele e consigliera di tutto il lavoro, non se ne cura. Dal loro primo incontro una strana alchimia prese forma e, su sua stessa ammissione, Marc la faceva volare, mentre lei lo teneva con i piedi per terra. Dotata di grazia, intelligenza e carattere, si laureò in letteratura all’Università di Mosca, di solito non accessibile ai figli di ebrei e seguì sempre i suoi sentimenti, anche a dispetto della sua stessa famiglia.
Come era accaduto per Marc Chagall, anche per lei il loro incontro segnò un punto di svolta, un cambiamento che avrebbe condizionato la sua esistenza, così come la reciproca produzione artistica. Con una scrittura potente, una prosa immaginifica e mistica, Bella lascia una piccola parte di sé, una ulteriore traccia di una vita in continuo dialogo con il suo amato. Ed è assecondando questa loro dimensione privata che lei inizia il suo memoriale, come fosse scritto solo per Marc, E mi sono ricordata che tu, amico mio devoto, spesso mi chiedevi di raccontarti della mia vita, del tempo in cui ancora non mi conoscevi.(B.C.)
Il primo incontro con Chagall è descritto con grande suggestione anche da Bella. Lei è di ritorno da un viaggio e vuole correre subito dalla sua più cara amica per raccontarle ciò che le è accaduto. Si precipita a casa di Thea parlando con foga e ridendo. Ma all’improvviso si accorge che non sono sole, qualcuno le sta ascoltando.
Chi è laggiù…ho paura. […] La porta, senza fare rumore si apre. Mi brucia la schiena. Sono inchiodata al mio posto. Ho paura di girarmi. Una fiamma sembra inseguirmi. La vedo scivolare lungo i muri. Un viso di ragazzo prende forma. Un viso bianco quanto la parete. (B.C.)
Lei è meravigliata, sa di non averlo mai visto prima e quello strano ragazzo Gesticola come se temesse di tornare sulla terra.Ha i capelli ricci, spettinati. Ma quando gli occhi si aprono un varco blu, venuti dal cielo. Occhi stranieri, non come quelli di tutti, lunghi, a mandorla. […] simili a un fauno. Bocca spalancata, non so se intenda parlare o mordere con i suoi denti bianchi e taglienti. Tutto in lui è movimento, come un animale a riposo pronto a spiccare un balzo in qualunque istante.
Nessuno di noi dice una parola. Ognuno di noi sente battere il cuore dell’altro. (B.C.)
Bella è sconvolta, vuole scappare via da quella situazione e nonostante faccia del tutto per non pensare a quell’incontro, come un doppio, il viso del ragazzo mi accompagna, respira, mi sussurra all’orecchio. Lo caccio via, torno da un altro lato. Questo artista la cui immagine mi insegue è come una stella cadente. Non la si può afferrare. Lui non si lascia portare via così facilmente. È sconcertante. (B.C.)
Lei non vuole che qualcuno legga i suoi pensieri, osservi il suo viso dopo aver incontrato quello strano ragazzo. Aveva già conosciuto altri artisti, ma nessuno l’aveva impressionata così. Corre via, non vuole vedere né lui né la sua amica. Sente che ridono di lei. Ma li ritrova su un ponte, poco dopo. Non oso alzare gli occhi e affrontare lo sguardo del ragazzo. I suoi occhi sono ora grigio-verdi, cielo e acqua. Per caso è nei suoi occhi o nel fiume che sto nuotando? (B.C.)
Quando parla mi sconcerta. Ogni parola sembra provenire da un mondo diverso.
Lui vuole che lei guardi una nuvola. Da subito le parla come se lei conoscesse il suo linguaggio, come se potesse trasportarla nel suo mondo senza problemi. E lei capisce cheUna voce nuova mi risuona dentro, simile all’eco di un pozzo profondo. …un sogno profondo mi abbraccia. Comincio a vivere tutta un’altra vita. (B.C.)
Così lei lo accoglie, da subito, nella sua interezza, lo circonda di grazia e affetto. Per il primo compleanno di Chagall, ancora giovanissima, Bella vuole festeggiarlo, «Mi ricordo ancora come mi scorticai le mani tentando, sopra una siepe, di strappare dei fiori azzurri dal gambo lungo».Si reca sul fiume, dove vive lui e dove, per la prima volta lei ispirerà uno dei quadri più celebri dell’artista.
Ho ancora i fiori in mano. Non riesco a stare ferma.[…]Ti sei gettato sulla tela che vibra sotto la tua mano. Intingi i pennelli. Il rosso, il blu, il bianco, il nero schizzano. Mi trascini nei fiotti di colore. Di colpo mi stacchi da terra, mentre tu prendi lo slancio con un piede, come se ti sentissi troppo stretto in questa piccola stanza. Ti innalzi, ti stiri, voli fino al soffitto. La tua testa si rovescia all’indietro e fai girare la mia…Mi sfiori l’orecchio e mormori…, scrive Bella Rosenfeld nelle sue memorie. Mentre lui semplicemente le domanda Tornerai domani? Dipingerò un altro quadro…Voleremo via.
E lo hanno fatto, si sono innalzati sopra l’orrore delle guerre, sopra la povertà e le ingiustizie dell’antisemitismo, hanno attraversato campi di fiori, cortili, sinagoghe e hanno volteggiato, insieme, combattendo con l’amore e l’arte.
All’improvviso però, dopo essersi trasferiti in America, Bella contrae una malattia e muore. «Il tuono rimbombò, un diluvio si abbatté alle sei di sera del 2 settembre 1944 quando Bella lasciò questo mondo. Tutto è divenuto tenebra». (M.C)
Tutto il mondo di Marc si sgretolata e l’unico luogo in cui potersi sentire a casa d’improvviso svanisce. Così la sua arte, che da sempre era stata illuminata e protetta quell’amore coinvolgente e segreto che custodivano. Lui non dipinge per quasi un anno e anche quando tornerà a vivere, a risposarsi, una certa malinconia lo accompagnerà per sempre.
Continuerà a celebrare la sua amata nei quadri, a invocarla e soprattutto a dipingerla come un angelo, una misteriosa figura pronta a consolarlo.



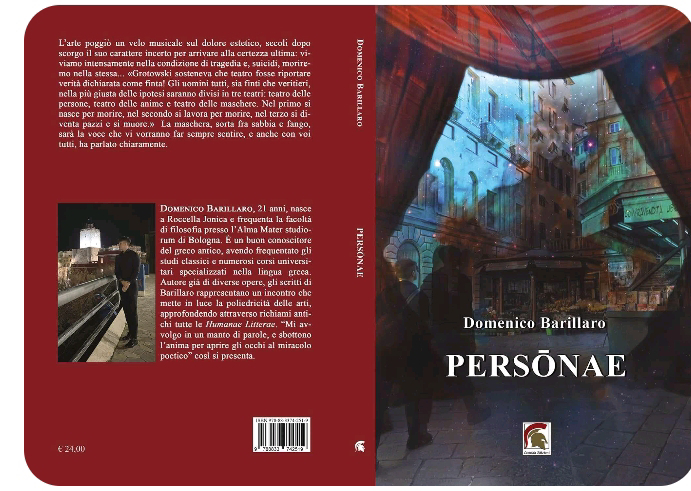

Bellissimo racconto , emozionante .
RispondiElimina